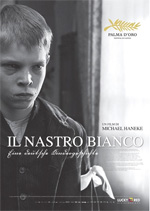 Michael Haneke ci trasporta nel microcosmo di un villaggio tedesco alla vigilia della prima guerra mondiale. Uno spazio dominato da due poteri oppressivi, quello religioso del fondamentalismo protestante e quello politico-economico del feudalesimo. Il racconto viene scandito, in parte, da una voce narrante fuori campo che è quella del Maestro che arriva nel villaggio, il resto è caratterizzato dal punto di vista dell'obiettivo cinematografico del regista che fruga dentro le abitazioni delle case. Così siamo testimoni delle azioni quotidiane dell'intero villaggio: troviamo un Pastore che educa rigidamente i suoi figli legandoli simbolicamente un nastro bianco ogni volta che questi violano la "giusta" condotta (questo gesto serve per ricordarli di custodire ossessivamente la loro innocenza), osserveremo la relazione clandestina e sadomasochista tra una bambinaia e un dottore rimasto vedovo con due figli a carico, il rapporto difficile tra un barone e sua moglie e, sopratutto, il gelido silenzio obbediente di tutti i figli di queste famiglie.
Michael Haneke ci trasporta nel microcosmo di un villaggio tedesco alla vigilia della prima guerra mondiale. Uno spazio dominato da due poteri oppressivi, quello religioso del fondamentalismo protestante e quello politico-economico del feudalesimo. Il racconto viene scandito, in parte, da una voce narrante fuori campo che è quella del Maestro che arriva nel villaggio, il resto è caratterizzato dal punto di vista dell'obiettivo cinematografico del regista che fruga dentro le abitazioni delle case. Così siamo testimoni delle azioni quotidiane dell'intero villaggio: troviamo un Pastore che educa rigidamente i suoi figli legandoli simbolicamente un nastro bianco ogni volta che questi violano la "giusta" condotta (questo gesto serve per ricordarli di custodire ossessivamente la loro innocenza), osserveremo la relazione clandestina e sadomasochista tra una bambinaia e un dottore rimasto vedovo con due figli a carico, il rapporto difficile tra un barone e sua moglie e, sopratutto, il gelido silenzio obbediente di tutti i figli di queste famiglie.
Saranno degli strani ed esplosivi episodi di violenza che si verificheranno nel villaggio a rompere quel silenzio, alcuni episodi sembreranno essere incidenti del tutto casuali, altri no. Più la narrazione corale si schiude più quegli incidenti sembreranno premeditati, acquisendo l'aspetto di una "punizione".
La violenza raccontata dal cinema di Haneke ha un'impatto sempre molto forte, perché viene mostrata con la spietatezza documentaristica di un entomologo: il comportamento della comunità umana viene analizzato in tutte le sue sfaccettature, anche quelle meno rilevanti ad un primo sguardo, così che anche se non ci è dato vedere il responsabile degli atti criminali, ci è possibile comprendere i "moti sociali" che potrebbero alimentarli, ma badate bene che non vi è alcuna semplificazione psicologica o giustificazione morale di sorta in questi atti, il film si limita a rappresentare, con estremo equilibrio, la collisione tra coscienza collettiva e individuale. A questo proposito è esplicativa la sequenza del lago in cui uno dei due bambini proletari ruba lo zufolo al figlio del barone perché non riesce a costruirne uno con i suoi mezzi, qui la violenza assume esattamente la caratteristica di una frustrazione derivata dal divario di classe. Queste azioni avvengono sempre sotto la silenziosa complicità degli altri bambini, una complicità che si rivela essere sempre più diffusa nel villaggio, basti pensare alla sequenza iniziale del film in cui alcune bambine uscite da scuola si dirigono insieme formando un blocco attorno a Clara, la figlia più grande del Pastore. Karli, il figlio disabile della bambinaia che ha avuto clandestinamente con il dottore, verrà ritrovato con gli occhi cavati e un biglietto che precisa che quell'atto barbaro è il frutto di una "punizione divina". Quando viene portato dentro casa dalla madre c'è una sequenza in cui Clara insieme ai bambini del villaggio vengono sorpresi dal Maestro mentre spiano attraverso la finestra dell'abitazione. Sono lì per preoccupazione delle condizioni di Karli oppure perché vogliono capire se Karli dirà qualcosa? L'ambiguità è padrona e copre gli eventi con un grande velo di inquietudine. Haneke in questo è un vero maestro perché come spesso viene detto dai suoi stessi collaboratori è capace di scaturire, attraverso la sua inconfondibile estetica, la cosiddetta "nota stonata": una sensazione di disagio che si manifesta anche in una sequenza perfettamente tranquilla e ordinaria. Haneke non solo rappresenta con perfetta coerenza la realtà, ma la trascende attraverso l'energia del montaggio, l'uso naturale del sonoro, della recitazione minimalista e di una fotografia gestita da Christian Berger quanto mai simbolica: l'uso del bianco e nero qui è perfetto, sembra pulizia estetica con i suoi bianchi tenui, ma scatenano delle ombre che sottolineano l'oscurità nei lineamenti dei volti dei bambini. Non è da trascurare il rigore formale della composizione degli elementi nelle inquadrature che amplificano la plasticità delle emozioni dei personaggi in modo che ogni loro reazione ci appaia rivelare qualcosa di profondamente importante ai fini della storia. C'è anche un saggio uso del fuori campo durante le scene di violenza fisica che, come accade nel cinema di Robert Bresson, è svuotata del suo consumo sfacciatamente visivo, sfruttando l'immaginario dello spettatore. L'assenza di un accompagnamento musicale dà spazio ai respiri, ai lamenti e ai silenzi inquieti dei personaggi.
Devastante, probabilmente una delle più riuscite, è la sequenza in cui Martin, il figlio del Pastore, viene accusato di onanismo: durante il dialogo l'oggetto della discussione non viene mai enunciato, al membro maschile viene assegnata l'enunciazione «là dove la legge divina ha eretto una sacra barriera». Il pene è uno spazio sacro che è stato violato, come se il corpo e i suoi desideri non appartenessero più alla stessa persona, le lacrime del bambino esplodono, manifestando il peso che grava sul suo senso di colpa. Immediatamente dopo la sequenza delle accuse del Pastore a suo figlio, arriva la sequenza che mostra la bambinaia e il dottore praticare del sesso anale, squallidamente, come un vano tentativo di ricostruire il loro rapporto. Il sesso è represso dalla morale protestante della comunità e quando viene vissuto si manifesta attraverso rapporti di dominazione e sottomissione. C'è un'altra sequenza sul tema che è particolarmente efficace, si tratta di quella in cui il piccolo figlio del dottore sorprende suo padre e sua sorella nello studio medico nel pieno della notte, Haneke organizza la composizione nel campo dell'inquadratura in maniera tale da suggerirne un senso di intimità interrotta: posiziona il dottore di spalle al figlio accanto alla figlia seduta sul lettino, lasciandolo in quella posizione per tutta la durata della sequenza senza mai farlo voltare, il dottore non guarderà mai direttamente negli occhi suo figlio mentre sollecita la figlia di accompagnarlo a letto perché ha fatto un incubo. Le parole della sorella per confortarlo appaiono vaghe, imbarazzanti e falsamente consolatorie. Anche se nell'inquadratura non c'è alcuna prova diretta, la sensazione che poco prima si stesse consumando un rapporto sessuale serpeggia nell'atmosfera. Ed è attraverso questa ambiguità che la scena comincia a costruirsi lentamente nella mente dello spettatore: il padre rimane girato per tutta la durata della scena perché ha la cerniera dei pantaloni aperta? Possiamo definire il cinema di Haneke come un'astuta "visione negata": risveglia l'intuizione e porta alla coscienza associazioni disturbanti.
Il finale del film è alquanto spiazzante, anche quando le prove sembreranno più evidenti e la teoria sulla colpevolezza dei bambini formulata dal Maestro sarà quella più accreditata, l'indagine verrà immediatamente fermata dalle minacce del Pastore. Il fondamentalismo non può mettere in discussione nessuno dei suoi valori e metodi educativi, ma il negazionismo del Pastore di fronte alla manifestazione del male, non farà altro che affermarlo prepotentemente. Se pensiamo che quei bambini saranno i futuri adulti che indosseranno le divise dell'SS e che aderiranno al "cristianesimo positivo", questa visione non ci lascerà in pace. Come afferma Haneke nelle sue interviste, la sua ricerca mostra come i valori del fondamentalismo religioso riversati da generazioni in generazioni, predispongono alla mistica del nazi-fascismo. Il film si chiude piazzando la macchina da presa sull'altare della Chiesa del Pastore, così che l'occhio dello spettatore è in corrispondenza con essa, dissolvendosi lentamente nell'oscurità, come la presenza buia di Dio di fronte all'umanità.
Il nastro bianco è un film che mortifica e disturba come pochi e lo fa in maniera silenziosa rinunciando a una violenza sfacciatamente visiva. Questa volta Haneke tratta con estrema delicatezza e coerenza il suo materiale e raggiunge il culmine della sua poetica già tracciata nella trilogia della glaciazione (Il settimo continente, Benny's Video e 71 Frammenti di una Cronologia del Caso), tra il rigore estetico di Dreyer e il fuori campo di Bresson, completa la sua ricerca e firma il suo capolavoro.



















Mmm... il secondo sarà Lourdes, ma il terzo? :D O ho un buco clamoroso io, oppure è un film di cui non si è parlato nei nostri blog :D
RispondiEliminaCi sarà sicuramente Lourdes, sotto una chiave definitiva, ci ho pensato a lungo.
RispondiEliminaMentre il terzo è una cosa nuova ovviamente, un film parecchio interessante, mi sa che non l'hai ancora visto.